Non sempre il titolo di una raccolta poetica risulta così aderente e organico al tema conduttore in essa contenuto. Parafrasando la Dickinson, alla guisa del bandolo “d’argento e di perla”, il titolo scelto rammenda e lega i testi presenti: parlo de “Lo scatto della lucertola” di Tiziana Marini, raccolta edita da La Vita Felice, 2016, con la prefazione di Sabino Caronia.
In questo frangente il titolo, tratto da una poesia inclusa nel libro che da il nome anche alla prima sezione, non solo è polisemicamente evocativo, tanto che la felice scelta meriterebbe un ragionamento a parte, ma aderisce perfetto al contenuto presentato e, abilmente, come un corrimano, lo supporta accompagnando il lettore.
Il tema (im)portante è quello, di resistere ai colpi inferti dalla vita, con le oscillazioni che ne derivano tra il godimento (per fortuna) di fatti gioiosi, e la perdita, il dolore, il senso di colpa dovuto alla distrazione, alla fretta, o a una riflessione mancata, una parola omessa, per non aver saputo (voluto) sostare un po’ di più accanto a qualcuno/qualcosa, (se stessi?), che il quel momento, richiedeva la nostra presenza o la nostra attenzione. Azioni e parole mancate, riflessioni e sentimenti pervasi quindi da una consapevole nostalgia, da una elaborazione del lutto verso ciò che è stato e più non sarà, e anche verso ciò che non è stato e avrebbe potuto essere. Ma forse non è l’intera produzione artistica nella sua autenticità, quando cioè libera da imposizioni di “mercato”, mossa da una elaborazione luttuosa contro la fine del tutto? Non è compito dell’arte, forse, lasciare un segno-testimone in un tempo che superi e vada oltre la nostra stessa esistenza? Testi, dunque, quelli di Tiziana Marini, basati sulla mancanza, e ancor di più, in modo ossimorico, testi da cui si evince l’arte di sopravvivere alla vita stessa, un modus operandi, – poiché non c’è poesia che non comporti azione -, nel tentare degli escamotages per la sopravvivenza, appunto, e pause di respiro nel vortice della vita stessa, attraverso quello scarto-scatto temporale e asincrono, da cui scaturiscono gocce di eterno, e che solo il componimento poetico permette di creare. Oltre alla follia naturalmente, intesa come diretta emanazione non filtrata dall’io-ragione, del linguaggio simbolico dell’inconscio, quando non addirittura nella zona impervia del pre-testuale. Strumenti ambedue, poesia e follia, seppure su piani diversi, portatrici di nuove semantiche che permettono di dire l’indicibile, cioè quanto di più legato al profondo, latente nel pre-verbale, e comunque riconducibile al disagio, consapevole o rimosso che sia, e ad un vissuto che, altrimenti, giacerebbe sul fondo inespresso.
Sopravvivere, dunque, stoicamente, ai colpi inferti dalla vita. Vita che ferisce e mutila. E allora come non pensare alla lucertola – e torniamo al titolo, nonché alla poesia – e al suo ultimo atto disperato che è quello di sacrificare una parte di sé, la coda, sul campo di battaglia, cercando di distrarre la malasorte, e con un scatto repentino e vitale, tentare la fuga verso la via della salvezza? Scrive infatti la nostra Autrice:
[…] Io sto bene anche a casa, da sola
mentre una parte del mondo è sveglia
cammina muore. A mio modo anche io sono sveglia
cammino e muoio, ma non lo spiego.
Ho in me lo scatto della lucertola, segreto.
Difficile evitare un parallelo con un’altra amatissima poetessa, il Premio Nobel Wislawa Szymborska, che in sintonia allegorica per la figura retorica scelta, scrive in “Autotomia“:
In caso di pericolo, l’oloturia si divide in due:
dà un sé in pasto al mondo,
e con l’altro fugge. Si scinde in un colpo in rovina e salvezza,
in ammenda e premio, in ciò che è stato e ciò che sarà.
Nel mezzo del suo corpo si apre un abisso
con due sponde subito estranee.
Su una la morte, sull’altra la vita.
Qui la disperazione, là la fiducia.
Se esiste una bilancia, ha piatti immobili.
Se c’è giustizia, eccola.
Morire quanto necessario, senza eccedere.
Rinascere quanto occorre da ciò che si è salvato.
Già, anche noi sappiamo dividerci in due.
Ma solo in corpo e sussurro interrotto.
In corpo e poesia.
Da un lato la gola, il riso dall’altro,
un riso leggero, di già soffocato.
Qui il cuore pesante,
là non omnis moriar,
tre piccole parole, soltanto, tre piume di un volo.
L’abisso non ci divide.
L’abisso ci circonda.
Quindi la vita ferisce e sottrae, taglia e mutila di varie parti la nostra esistenza emotiva e fisica. E cosa rimane del vivere, di tutto questo soffrire, sul campo di battaglia? E’ la domanda eterna, a volte muta, che latente percorre la produzione di ogni artista di ogni tempo, poiché l’arte, con i suoi dislivelli percettivi e con i suoi voli, a volte altissimi a volte rasi al terreno, erompe, crea varchi atemporali, crepe nel muro della logica e della ragione, in cui la lingua poetica, scritta e parlata, diventa, dice Giorgio Agamben, “…come una sonda nel luogo del mistero, fra dei e demoni, fra oblio e ricordanza…”. Arte, quindi, intesa come medium più idoneo per la ricerca del latente inespresso, de ”L’indicibile sottratto al nulla (DI POESIA E DI PSICOANALISI)”(1), che è stato anche il titolo di un interessante convegno, svolto a Milano, nel giugno del 2017, che verteva anche sul valore alchemico e sulla capacità di trasformazione della parola poetica quanto di quella psicoanalitica.
E in Tiziana Marini, attraverso le sue liriche accuratamente limate, ben strutturate da un ritmo sapiente e incalzante, sostenute da un disegno ellittico del verso, asciutto eppure aggraziato, mai duro, con chiuse a volte davvero sorprendenti, armoniosamente la nostra Poetessa ribadisce e riformula la domanda atta a svelare il vuoto attorno alle parole. Ed è una lotta contro vento, contro corrente e contro il “Nulla”, che costantemente accompagna il (nostro) vivere. Infatti, con la poesia intitolata Eravamo il mare, che più avanti riprenderò, in alcuni versi l’Autrice afferma:
[…] << Non senti i passi del ritorno, nell’andare? Li riconosci?>> ti dicevo.
E tu: << Quanto dura la morte nell’arco della vita? […]
Nella complessità di un percorso poetico di grande espressività iconica, come quello della Marini – e qui ricordo che la nostra è anche artista visiva – chi scrive conduce in una vastità emotiva offrendo una gamma di lettura strutturata su più piani. Sta al lettore saperli cogliere: sono piani da scoprire, oltre che dalla sensibilità soggettiva, o dal momento storico attraversato, anche mediante un lavoro di rilettura attenta, raffinata, e, quando possibile, con collegamenti, associazioni riguardanti la biografia dell’autrice, o dell’autore più in generale, che vanno a costruire quel che sempre manca nei versi a causa della finitezza insita nella parola stessa: il contenuto alluso, il non detto. Sempre Agamben, nel suo libro Il fuoco e il racconto, arriva a chiedersi se il vero luogo della poesia “non sia per caso né in una pagina, né nell’altra, ma nello spazio vuoto fra entrambe” (quindi ancora il non detto), in cui il contenuto palesato, reso possibile pur dal limite che ogni lingua presenta, diventa percorso nella direzione di quanto omesso, verso il contenuto alluso rimasto nella penna dello scrittore, se non addirittura a lui del tutto sconosciuto. Un buon uso della parola poetica ci attira esattamente in questa dimensione, ed è una parola, che pur portando un indiscusso valore oggettivo di per sé, ne comprende anche altri sottostanti, soprastanti e a latere. Per questo la parola poetica di Tiziana Marini evoca dimensioni linguistiche altre e parallele, emozionali, vibrazionali. Se fosse canto useremmo il termine ipertonico, cioè il suono multiplo insito in un’unica voce, la cui resa rimanda ad un’opera quasi corale. Con la sublime grazia della parola dono, con una scrittura solo apparentemente diaristica, e alla stregua di egregie, quanto amate, poetesse italiane e internazionali, il verso della Marini ci inoltra in un quotidiano in cui si cela lo straordinario. Allora è riscoperta, è gioia, ma anche perdita, dolore, abisso:
Per tutte le volte che non ti ho abbracciato
presa da fretta o da dimenticanza
io mi rimprovero
considerando il tempo troppo breve.
Se mi fossi fermata
scintillando l’universo come al primo abbraccio
più e più fili avrei intrecciato
per legare al mondo, tesserlo
per legarci noi in una trama, immortali.
E questi bellissimi, intensi versi dedicati come un addio alla madre, in cui la dimensione temporale concede l’ultima cena, l’ultimo dono, l’ultimo saluto. Dopo è ricordo, talvolta oblio:
Curva sul piatto dell’ultima cena
un ultimo dono
la cipollina all’aceto di-vino
in mezzo ai chicchi di riso.
La sorpresa e un sorriso
di gratitudine eterna che di certo hai portato con te.
Ti chiedeva perdono la morte
e un po’ anche la vita.
Quindi dolore, separazione da chi più abbiamo amato, da chi abbiamo intimamente appreso l’arte della parola, la lingua-madre, un dolore che ci accompagna dalla nascita e che segna in modo più evidente, una scissione tutta al femminile: quella di una figlia dalla madre, e viceversa. Un percorso a volte durissimo, quello della distinzione, che può gettare distanze feroci, e che pure porta, faticosamente alla costruzione della propria identità indipendente, sebbene uguale nel genere, ma diversa. Un percorso spesso accompagnato da sofferenza e solitudine, poiché tutto, ma proprio tutto quello che ci riguarda, scivola e si muove sul piano simbolico delle nostre azioni, della nostra Poiesis. Allora diventa un fatto straordinariamente poetico scoprire “…l’epica distanza tra le foglie”, oppure constatare che: “ …Dondolare…E tutto il cielo, tutto il cielo sotto.” ; e ancora:
Volando a collo teso
verticale al mondo
e obbediente
ho chiuso da far male gli occhi
per stringere la notte.
Li ho serrati forte
per vedere nel mio buio
caso mai le stelle.
E non essere altro da sé, non riconoscersi in altro, se non nella linea ininterrotta tra sé e il tutto, per antico richiamo delle particelle che internamente, per struttura di una regola dettata, si ascrivono all’universale – per questo ed altro ancora, non esisterà mai una scrittura solamente “intima” o “autobiografica” che non richiami ad un certo “esperito” o vissuto esperienziale, cioè la vera conoscenza, se è altrettanto vero che la vita esiste solo attraverso la sua narrazione: “…Noi quel giorno eravamo il mare.”, dice la Poetessa Tiziana Marini, in un’altra bella poesia: ritrovarsi dunque, non davanti al mare per un fatto meramente occasionale o generico non meglio descritto, ma ci si ritrova ad essere molecolarmente mare; per uno stato di grazia che talvolta ci attraversa, per una dimenticanza di sé, per una capacità davvero epica di immersione totale nei fatti del mondo e nelle sue manifestazioni, verso cui, seppure dolorosamente, un poeta, autentico testimone di tali fatti, non si sottrae: per mandato karmico se si vuole, o per intima vocazione.
Stefania Di Lino
![]()

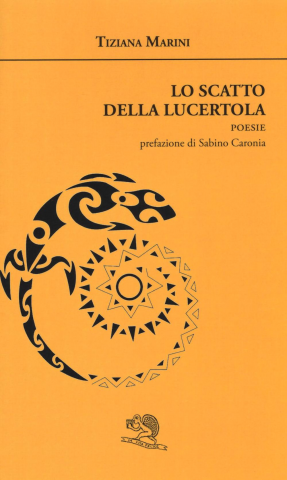
2 Comments
Ringrazio Stefania Di Lino per questo saggio profondo e centrato sulla mia raccolta di poesie e per la sensibilita’ nel cogliere l’ispirazione che ne e’ alla base. Ringrazio il sito per l’ospitalita’
Tiziana Marini
Grazie per il dono delle tue parole, cara Tiziana.
By Post Author