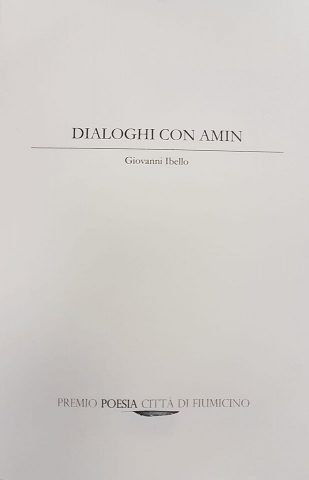 “La poesia è un lunghissimo addio”.
“La poesia è un lunghissimo addio”.
Comincia così il poemetto di cui ho l’irriverenza di parlare sfidando dico, soprattutto, la proverbiale ritrosia dell’autore alle lusinghe pubbliche. Cercherò finché possibile, dunque, di sorvolarla la poesia, guardarla mentre recita la sua rivelazione.
Ho letto il poemetto durante le sue fasi di lavorazione e mi dico che forse il modo migliore per commentarlo sarebbe tacerne. Lasciargli totalmente la parola. Mettersi nella condizione dell’ascolto assoluto, assorbire, quasi religiosamente, quel corpo dilaniato dai versi che evocano un ultimo respiro, nello spazio vuoto interminabile, appunto, di un addio: un’ombra o se volete un attrito di ombre nell’intima sopravvivenza della voce che canta come per resistenza.
Questo pretenderebbero i versi di Giovanni: metterci nella piega di una preghiera, ustionarci col silenzio che la eleva, fino a farci scomparire in essa, consumati in quel suono dissoluto, un addio quasi fisico, irripetibile ma non definitivo.
Lo scenario (post-apocalittico) produce una modulazione sonora interrotta da continui precipizi, da un susseguirsi di vuoti tenuti in un loro grembo sorgivo, in una loro culla sonora diciamo così embrionale. Dal punto di vista linguistico, la messa a fuoco di un fossile incastrato nell’ambra, giù giù lontano nella gola, fino a toccarne gli apici, fino a sentirsene invasi.
E’ una parola panica che deve per forza trovare la sua radice in una caduta e la prima immagine che arriva agli occhi del lettore ha proprio l’impatto di una caduta. Si è come sprofondati, dunque risvegliati, dal rumore stesso delle parole disseminate su un paesaggio ridotto a brandelli, al centro di una esplosione che è imminente ovvero lontanissima, lasciata lì da chissà quanti secoli.
Quello che le parole di Giovanni raccontano sin dai primi versi è proprio il silenzio (che diventa preparazione al silenzio per il lettore). Ed è questa preparazione al silenzio la cosa più significativa per il lettore: penetrare la cifra di ogni singola scaglia di suono mentre si osserva dall’alto una pineta bruciata, desolata. La sua voce entra col tono tragico ma nello stesso tempo è rassicurante. Lì c’è un corpo minuscolo con dentro tutto l’amore del mondo e noi siamo già in grado di toccargli gli occhi e le ossa, di vederlo come un simbolo, di sentirne ogni scossa.
E’ la parola che si apre lenta come un fiore oppure brucia nell’ultima brace, il nucleo che ci contiene miracolosamente, quella che Luzi ha definito con un assioma assoluto “la ferita nell’essere”. E’ questa l’unica salvezza possibile: schiodare il verbo nel suo grido di carne, trovarne l’esatto perimetro, stare nell’assoluto atemporale fiutando la luce nel grembo di una cancellazione e individuare il resto una sagoma. E’ questa la distanza che Giovanni indovina: che è distanza tra l’io narrante e il personaggio in primo piano: destino indiviso per chi si ama nel buio degli hangar e nell’amore si fa multiplo; un “noi” unico e universale che è principio di ogni altezza sublime come formula necessaria, la sola realmente possibile, della Poesia. La lingua ne è perfettamente impregnata e prosegue per tutto il poemetto così, preparandoci da subito alla presenza di questa magica figura che poi uscirà completamente allo scoperto: Amin, figura archetipica, molto simbolica, luogo dell’anima o, se possibile, dio della parola, gheriglio di stelle, anatema.
Giovanni Perri
———-
Cercava la risacca nelle pinete
fiutava l’ombra di un ago sul fondale,
la panacea di un abbandono.
Conta fino a zero, le dissi
salta nell’arco cinerino.
E’ tutto calmo
qui è davvero tutto calmo
il sole è una biglia di benzodiazepina.
C’è ancora un intreccio
di gelsomini carbonizzati sulla pietra,
L’estate,
una valanga di aceto sopra i fiori.
Ma in questo valzer di occhi crociati
non dire una parola,
non parlare.
Troveremo un altro modo per fare alta la vita.
———-
La mia estasi rimane
lettera morta sul greto.
Brindo al disamore
al cuore profanato nell’acquaio
agli insetti fulminati nell’insegna.
Ci lega la parola feroce,
una giostra di penombre.
L’incanto di una teleferica,
l’esatto perimetro di un grido,
tu che muori
in quell’assillo di aranceti
che ritorna.
Era l’affanno antico,
l’anemone del giorno
divelto sopra i silos.
———-
La risacca ci insegna il solo rito possibile: lo smisurato addio.
———-
Amin, il volo a trapezio dei cormorani è un alfabeto senza luna.
Avrai una stella di cenere sul fianco, uno stecco di mezzaluce. Una
spilla conficcata nel cuore di neve, la tua parola sarà l’inganno, la
Mesopotamia dell’invisibile: uno che batte furiosamente il viola dei
polsi sulla rena. Fermati, fermati primavera.
* (“Dialoghi con Amin” di Giovanni Ibello, già Premio Poesia Città di Fiumicino 2018, edizioni Corte Micina)
Giovanni Ibello (Napoli, 1989), vive e lavora a Napoli. Nel 2017 ha pubblicato per Terra d’Ulivi il suo primo lavoro in versi, “Turbative Siderali” (premio Como opera prima, finalista al premio Ponte di Legno e al Camaiore proposta). L’opera è stata recensita su diversi blog e riviste letterarie. È redattore di Atelierpoesia.it e collabora con il blog di poesia della Rai di Luigia Sorrentino. Le sue poesie sono state tradotte in Spagna, Messico, Colombia, Russia e Romania. Nel 2018 si aggiudica il premio Fiumicino per l’opera inedita.
Nel 2018 è stato ospite di Casa della poesia per il progetto “Intrecci”, insieme ad Eleonora Rimolo.
![]()
